“Sostieni il sito con un semplice clic sui banner: solo un gesto per aiutarci a continuare a offrirti nuovi contenuti!”
“Sostieni il sito con un semplice clic sui banner: solo un gesto per aiutarci a continuare a offrirti nuovi contenuti!”

Il secolo aveva da poco smesso di essere bambino quando un giovane di ventiquattro anni salì su un treno alla Union Station di Washington D.C. Il suo biglietto era di sola andata, la sua destinazione era un mito in costruzione chiamato Harlem, e il suo bagaglio consisteva in un vestito logoro, una gracile sicurezza in se stesso e una melodia nuova che gli ronzava in testa, nata dal ritmo ipnotico delle rotaie.
Si chiamava Edward Kennedy Ellington. Ma già allora, per gli amici del quartiere e per le signore che lo vedevano passare con quel portamento da aristocratico, era semplicemente “Duke”. Il Duca. Un titolo auto-conferito, un’armatura di eleganza forgiata per proteggere un ragazzo di colore dall’asprezza del mondo, e forse per prepararlo a conquistarlo.
Guardava il paesaggio della sua giovinezza sfumare nel finestrino, sostituito dalle promesse grigie di Newark e poi dai primi, elettrizzanti lampioni di New York. Forse in quel momento, nel rombo del treno, non sentì solo il rumore del viaggio. Sentì il battito del destino. Era il battito di un metronomo gigante che avrebbe scandito i successivi cinquant’anni della musica americana. Era il ritmo del futuro. Era il ritmo del jazz, ma di un jazz che ancora non esisteva, che lui stesso avrebbe dovuto inventare.
Quel treno non trasportava solo un uomo. Trasportava un’intera orchestra sinfonica ancora silenziosa, un catalogo di melodie non ancora scritte, un vocabolario di armonie mai udite. Trasportava il futuro Re di Harlem.
Harlem negli anni ’20 era un crogiolo alchemico dove il piombo della segregazione e della povertà veniva, per miracolo, trasformato in oro puro: artistico, intellettuale, musicale. Era il cuore pulsante del Rinascimento di Harlem, e Duke Ellington ne divenne il ritmo cardiaco.
Il suo regno era il Cotton Club. Un luogo di paradossi stridenti: un tempio del divertimento esclusivo per un pubblico bianco e benestante, situato in un quartiere nero, con sul palco artisti neri che interpretavano caricature di “selvaggi” africani per il diletto dei clienti. Ma dentro quella gabbia dorata e razzista, Ellington compì la sua prima, geniale alchimia. Prese quelle costrizioni e le trasformò in arte sublime.
Il management voleva “musica della giungla”? Lui gliela diede. Ma non era la musica grezza e primitiva che si aspettavano. Era qualcosa di completamente nuovo, di sofisticatissimo. Dai palchi del Cotton Club, nell’oscurità percorsa da fasci di luce colorata, si levò il suono dell’orchestra di Duke Ellington: un organismo vivente, respirante, un’unica, immensa anima fatta di dodici, tredici, quattordici individui.
E che individui. Ellington non assumeva semplicemente dei musicisti; raccoglieva voci, personalità, timbri unici e irripetibili. Il genio di Duke non era solo nella composizione, ma nella orchestrazione delle anime. Lui scriveva non per uno strumento, ma per l’uomo che quello strumento lo suonava.
C’era il trombone gutturale, minaccioso e sensuale di Tricky Sam Nanton, che con la sordina “a papera” (il plunger) imitava il lamento di un uomo, il pianto di un bambino, il ruggito di un leone della giungla immaginaria del Cotton Club. Era il suono del growl, un lamento straziante e bellissimo che divenne il marchio di fabbrica della sua “jungle style”.
C’era la tromba d’oro e liquida di Bubber Miley, che con lo stesso plunger trasformava lo strumento in una voce stregata, un richiamo primordiale. Insieme, Miley e Nanton erano le fauci spalancate della notte di Harlem.
E poi c’era il suo alter ego, il suo braccio destro, l’architetto del suono: Billy Strayhorn. Un giovane compositore timido e raffinatissimo che bussò alla porta di Duke con una melodia che si chiamava “Lush Life”. Ellington capì immediatamente di aver trovato non un collaboratore, ma un’anima gemella. Strayhorn, che tutti avrebbero chiamato “Swee’ Pea”, divenne la sua penna più elegante, l’arrangiatore più sensibile, colui che avrebbe scritto quello che sarebbe diventato l’inno non ufficiale della band: “Take the ‘A’ Train”. La loro era una simbiosi così perfetta che spesso nemmeno loro stessi sapevano dove finisse la mano di Duke e iniziasse quella di Billy.
Fu in questo crogiuolo che nacquero i primi capolavori. “East St. Louis Toodle-Oo”, un pezzo dal titolo nonsense e dal sound ipnotico, divenne la sua prima signature tune. “Black and Tan Fantasy”, che fondeva il blues con un accenno della “Marcia Funebre” di Chopin, elevando il jazz a forma d’arte seria, capace di profonda malinconia. “Creole Love Call”, dove la voce di Adelaide Hall si librava come uno strumento fantasma, un lamento senza parole che fluttuava sopra l’orchestra, etereo e potentissimo.
Duke Ellington non stava solo suonando musica. Stava dipingendo quadri sonori. Stava raccontando storie. Stava forgiando un’identità. La sua musica era il suono dell’America nera: la sua eleganza, la sua sofferenza, la sua gioia sfrenata, la sua spiritualità profonda. Era complessa quanto un racconto di Dostoevskij ma immediata come un sorriso. Era musica per i piedi e per l’anima.
L’Apoteosi del Duca – It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)
Gli anni ’30 e ’40 furono l’era dello swing, e le big band erano le regine incontrastate della scena musicale. Ma l’orchestra di Duke Ellington non era una semplice big band. Era l’Orchestra Sinfonica del Jazz.
Mentre le altre band inseguivano il successo commerciale con melodie orecchiabili e ritmi facili, Duke continuava la sua esplorazione musicale senza confini. La sua orchestra era un laboratorio in perenne movimento, un treno in corsa (il famoso “A Train”) che raccoglieva nuovi talenti e li forgiava nel crogiolo del suono ellingtoniano.
Arrivarono nuovi protagonisti per i suoi drammi sinfonici. Johnny Hodges al sax contralto, il cui suono era così vellutato, così carico di un erotismo malinconico, che poteva far piangere una stanza piena di persone con una sola nota tenuta. Quando Hodges suonava un assolo, come in “Warm Valley” o “Prelude to a Kiss”, il mondo sembrava fermarsi per ascoltare.
Ben Webster al tenore, il cui fiato possente e ruvido era come velluto a coste, in grado di passare da un ruggito potente a un sussurro seducente in un batter d’occhio. Jimmy Blanton, un giovanissimo bassista che rivoluzionò il ruolo dello strumento, trasformandolo da semplice accompagnatore in una voce solista melodica e ritmicamente potente. La sua collaborazione con Duke in duetti come “Pitter Panther Patter” fu un punto di non ritorno per la musica.
E poi Cootie Williams, che ereditò la tromba con il plunger da Bubber Miley, e Barney Bigard al clarinetto, che portò il sapore creolo di New Orleans nel suono della band.
Con questa formazione stellare, Duke Ellington raggiunse vette inarrivabili. Scrisse brani che erano più che canzoni: erano miniature perfette, ritratti musicali. “Concerto for Cootie” era un pezzo scritto appositamente per mostrare la gamma espressiva di Williams, dalla potenza squillante al mormorio più intimo. “Jeep’s Blues” era un veicolo per il suono ipnotico di Hodges. “Ko-Ko” era un pezzo dal ritmo ossessivo e dalle armonie dark, un capolavoro di tensione e mistero.
Ma il suo capolavoro assoluto di quegli anni fu un’opera jazz lunga quasi un’ora: Black, Brown and Beige. Debuttò alla Carnegie Hall di New York nel 1943, un evento epocale. Per la prima volta, un compositore nero portava una suite di musica sinfonica ispirata alla storia del suo popolo nel tempio più sacro della musica classica americana. Era un’affermazione potente, un atto di orgoglio e di sfida. Raccontava in musica la storia degli afroamericani: il nero della schiavitù e del lavoro (“Work Song”), il marrone della lotta per la libertà (“Come Sunday”, un brano di spiritualità struggente), e il beige dei tempi moderni e delle complessità della vita urbana. Il pubblico e la critica furono spiazzati. Alcuni lo accusarono di aver abbandonato il jazz per ambizioni classiche troppo grandi. In realtà, Duke stava semplicemente facendo ciò che aveva sempre fatto: abbattendo i muri. Gli mancavano gli strumenti per esprimere ciò che sentiva, così li inventava. Black, Brown and Beige non era perfetta, ma era necessaria. Era la prova che il jazz poteva essere portatore di un messaggio profondo, poteva essere epico, poteva essere storia.
discografia
| Ellington at Newport | 1956 | Un album dal vivo che ha rivitalizzato la carriera di Ellington, celebre per la lunga performance di “Diminuendo and Crescendo in Blue”. |
| Such Sweet Thunder | 1957 | Ispirato alle opere di William Shakespeare, questo album presenta una suite di brani che riflettono personaggi e temi shakespeariani. |
| Black, Brown and Beige | 1958 | Suite sinfonica che narra la storia degli afroamericani, considerata uno dei lavori più ambiziosi e significativi di Ellington. |
| Anatomy of a Murder | 1959 | Colonna sonora del film omonimo, è un esempio innovativo di musica jazz applicata al cinema, con un sound blues e orchestrale. |
| Jazz Party | 1959 | Un album energico che cattura lo spirito festoso del jazz, con la partecipazione di ospiti speciali come Dizzy Gillespie. |
| The Nutcracker Suite | 1960 | Una rivisitazione in chiave jazz del celebre balletto di Čajkovskij, che dimostra la versatilità di Ellington. |
| Paris Blues | 1961 | Colonna sonora del film omonimo, con brani che evocano un’atmosfera blues e malinconica. |
| Money Jungle | 1962 | Un trio album con Charles Mingus e Max Roach, un capolavoro di improvvisazione e interazione tra tre giganti del jazz. |
| Duke Ellington & John Coltrane | 1962 | Una storica collaborazione tra due maestri del jazz, che unisce lo stile melodico di Ellington con l’approccio più sperimentale di Coltrane. |
| Duke Ellington Meets Coleman Hawkins | 1962 | Un incontro tra il “Duca” e uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz. |
| The Far East Suite | 1967 | Ispirato a un tour in Medio Oriente e Asia, questo album presenta composizioni che evocano suoni e atmosfere di culture lontane. |
| And His Mother Called Him Bill | 1967 | Album tributo a Billy Strayhorn, suo collaboratore di lunga data, un lavoro intimo e toccante. |
| … And His Mother Called Him Bill | 1967 | Un altro album tributo a Billy Strayhorn, suo collaboratore di lunga data. |
| New Orleans Suite | 1970 | Una suite dedicata alla città di New Orleans, culla del jazz, che celebra la sua storia e la sua cultura. |
| Togo Brava Suite | 1971 | Un album che esplora temi africani, con ritmi e sonorità ispirate al continente nero. |
| The Afro-Eurasian Eclipse | 1971 | Un album che fonde influenze africane, europee e asiatiche, un’opera audace e sperimentale. |
| Eastbourne Performance | 1971 | Un album dal vivo che cattura l’energia e il virtuosismo della band in concerto. |
| The Duke Plays Ellington | 1972 | Un album che presenta Ellington al pianoforte, in un’esibizione solista che mette in risalto il suo tocco unico e la sua maestria. |
| Latin American Suite | 1972 | Un album che esplora i ritmi e le melodie dell’America Latina, con brani che fondono jazz e musica latina. |
| Second Sacred Concert | 1973 | Secondo di tre concerti sacri di Ellington, che unisce musica jazz e gospel in un’opera spirituale e commovente. |
Il Pellegrino Globale – Al di là della Categoria
Il dopoguerra portò un terremoto musicale. Le big band, troppo costose da mantenere, entrarono in crisi. L’era dello swing finì, sostituita dal bebop, un jazz più intimo, nervoso e ribelle. Per molti, l’orchestra di Ellington era un relitto del passato, un dinosauro destinato all’estinzione.
Ma il Duca non era un uomo del passato. Era un uomo al di là del tempo. Invece di arrendersi, intraprese quello che lui chiamò il suo “Pellegrinaggio Globale”. Prese la sua orchestra e viaggiò. In Europa, in Medio Oriente, in America Latina, in Asia. Non era una tournée, era una missione diplomatica. Il Dipartimento di Stato americano lo mandò in giro per il mondo come ambasciatore della cultura americana, in piena Guerra Fredda. Era la migliore scelta possibile: Duke Ellington era l’America al suo meglio: creativa, libera, innovativa, elegante.
Questi viaggi non furono solo per esportare musica, ma per importare ispirazione. Il mondo divenne la sua nuova tavolozza. I suoni, le scale, i ritmi che assorbiva in questi luoghi lontani confluirono in una nuova, straordinaria fase creativa.
Dall’Inghilterra trasse ispirazione per le suite ispirate a Shakespeare e alla Regina Elisabetta. Dal vicino Oriente venne “Caravan”, con il suo ritmo sensuale e esotico, co-scritto con il trombonista di origini portoricane Juan Tizol. Dai festival internazionali nacquero incontri e collaborazioni con i più grandi musicisti del mondo, dai classici ai jazzisti moderni.
In questo periodo, Duke compose alcune delle sue musiche più ambiziose e spirituali. La Sacred Concert Music, una fusione di jazz, gospel, cori e recitazione, fu un’altra sua rivoluzione silenziosa. Portò il jazz in chiesa, o forse portò la chiesa nel jazz, creando una celebrazione gioiosa e commovente della fede. “Heaven”, cantata in quei concerti, è una delle melodie più pure e belle mai scritte.
Nonostante i cambiamenti epocali nella musica, l’Orchestra di Duke Ellington rimase un faro. Continua ad attrarre giovani talenti che volevano far parte della leggenda. Il saxofonista Paul Gonsalves divenne una star per caso durante il now famous Newport Jazz Festival del 1956. Durante l’esecuzione di “Diminuendo and Crescendo in Blue”, Duke gli indicò di suonare un assolo di collegamento tra i due brani. Gonsalves, ispirato, si lanciò in un assolo di sax tenore che durò ventisette cori, sei minuti e trenta secondi di pura, ipnotica energia ritmica. La folla, prima sedata, impazzì letteralmente, ballando nei corridoi e sugli schienali delle sedie. Quell’assolo, quell’energia, quel momento di pura magia jazzistica, resuscitò commercialmente la carriera di Duke e gli garantì la copertina di Time magazine. Era la prova che il suo linguaggio, la sua orchestra, poteva ancora parlare al presente con una forza primordiale.
Re per un Giorno, Duca per Sempre
Edward Kennedy “Duke” Ellington suonò e compose fino all’ultimo respiro. Morì il 24 maggio 1974, lasciando un vuoto che non sarebbe mai stato colmato. La sua eredità non è misurabile solo in numeri, anche se i numeri sono stupefacenti: oltre millecinquecento composizioni, decine di dischi fondamentali, innumerevoli premi, tra cui la Presidential Medal of Freedom, la massima onorificenza civile americana.
La sua vera eredità è fatta di suono e di spirito.
Inventò un universo sonoro unico e inconfondibile. Il “suono Ellington” è come un colore che solo lui possedeva: un misto di ombra e luce, di blues e di luce lunare, di grida della giungla e sussurri d’amore in un salotto elegante. Le sue armonie erano ricche, complesse, a volte dissonanti, ma sempre sorprendentemente melodiche. Prendeva accordi che nessuno usava e li rendeva necessari, inevitabili.
Ma più della tecnica, contava la filosofia. Duke Ellington rifiutò sempre di etichettare la sua musica come “jazz”. Per lui era una parola limitante, riduttiva. Lui suonava “musica americana”. Suonava la musica della libertà. La sua orchestra era la dimostrazione pratica di una democrazia ideale: individui fortissimi, con voci potentissime e personalità uniche, che trovavano la loro massima espressione all’interno di un collettivo. Ognuno era libero di essere sé stesso, perché quella libertà arricchiva l’intero organismo.
Era un narratore. I suoi brani erano spesso “ritratti musicali” di persone, luoghi o stati d’animo. Dipingeva con le note il mattino di New York (“Daybreak Express”), l’energia di un treno (“Happy-Go-Lucky Local”), la malinconia di un quartiere (“Harlem Air Shaft”), la bellezza di una donna (“Portrait of Mahalia Jackson”). La sua musica è un’affresco gigantesco della vita americana del XX secolo, visto attraverso gli occhi di un geniale, elegante osservatore.
Alla fine, il titolo di “Duca” si rivelò non una pretesa giovanile, ma una profezia. Non ereditò un regno, lo costruì nota dopo nota. Non governò con leggi o decreti, ma con la bellezza e il ritmo. Il suo regno non aveva confini geografici, esisteva nell’aria, nelle frequenze radio, nei solchi dei vinili, nel cuore di chi ascolta.
E ancora oggi, quando le note di “Mood Indigo” si alzano nell’aria, avvolte in quella celebre, melanconica combinazione di clarinetto, tromba con sordina e trombone, il suo regno si ricostituisce all’istante. Il Duca è sul palco, elegante come sempre, con un cenno del capo o un accenno di sorriso dirige la sua orchestra immortale. I suoi uomini, i suoi eroi – Hodges, Gonsalves, Strayhorn, Carney, Tizol – sono lì con lui, pronti a dare vita ancora una volta a quella sinfonia infinita in nero e oro.
Perché, come amava dire lui, “Il jazz è libertà”. E Duke Ellington, il Duca, il Re di Harlem, il Pellegrino Globale, è per sempre il sovrano di quel regno senza confini.
Il primo brano composto da Ellington, “Soda Fountain Rag”, nacque mentre lavorava come ragazzo delle bibite in un bar. Aveva appena 14 anni e non sapeva ancora scrivere la musica sul pentagramma, quindi imparò a suonarlo a memoria e lo trasmise oralmente agli altri musicisti. Quella composizione “accidentale” segnò l’inizio di una carriera che avrebbe cambiato la storia del jazz.
Molti pensano che Ellington abbia scelto il suo nome d’arte, ma in realtà fu un’idea degli amici di gioventù. Edward Kennedy Ellington si vestiva sempre in modo impeccabile e aveva un portamento elegante, tanto che i coetanei iniziarono a chiamarlo “Duke” (Duca) per prenderlo un po’ in giro. Il soprannome però gli rimase addosso e divenne il suo marchio di fabbrica.
Può sembrare incredibile, ma Duke Ellington affermò più volte di non voler essere definito un musicista di jazz. “Il jazz è solo una parola”, diceva. Per lui la musica non aveva etichette: era un’arte universale. Questo approccio spiega perché le sue composizioni spaziassero dal swing al blues, dalle sinfonie orchestrali alle colonne sonore.
A differenza di molti direttori d’orchestra, Ellington non imponeva prove interminabili alla sua band. Preferiva che i musicisti portassero la loro creatività sul palco, lasciando spazio all’improvvisazione. Questa libertà ha reso la Duke Ellington Orchestra una delle più innovative di tutti i tempi.
Duke Ellington aveva un dono eccezionale: poteva ricordare a memoria migliaia di brani. Spesso non scriveva subito la musica, ma la teneva nella mente per giorni, a volte per settimane, prima di trascriverla. Era come se il pianoforte fosse un’estensione del suo pensiero.
Il Cotton Club, dove Ellington divenne una stella negli anni ’20, era famoso per i suoi spettacoli sontuosi e la musica di altissimo livello. Ma c’era un paradosso: il pubblico era esclusivamente bianco, mentre sul palco si esibivano artisti afroamericani. Ellington non amava questa discriminazione, ma sfruttò quella piattaforma per portare il jazz a un pubblico più ampio.
Ellington era un animale notturno. Amava comporre di notte, in hotel o durante i viaggi in treno tra una tournée e l’altra. Scriveva ovunque: sul retro delle buste, sui tovaglioli, persino su carta intestata degli alberghi. Diceva che la notte gli dava “più silenzio e più musica”.
Durante le sue tournée internazionali, Ellington trovava ispirazione nei luoghi che visitava. Nel 1966, dopo un viaggio in Medio Oriente, scrisse “The Far East Suite”, un capolavoro che mescola jazz e suggestioni orientali. Allo stesso modo nacquero altre suite dedicate a città e culture diverse.
Negli anni della Guerra Fredda, Duke Ellington fu inviato in varie parti del mondo come ambasciatore culturale degli Stati Uniti. Il governo americano capì che il jazz poteva essere uno strumento di soft power, e nessuno meglio di Ellington poteva rappresentare l’eleganza e la creatività americana.
Pur avendo scritto colonne sonore memorabili, come quelle per il film “Anatomy of a Murder” (1959), Duke Ellington non vinse mai un Oscar. Fu però candidato e ricevette numerosi altri premi, tra cui 13 Grammy e la Medaglia Presidenziale della Libertà.
Non era solo una questione di vestiti costosi: Ellington credeva che l’eleganza fosse una forma di rispetto per la musica e per il pubblico. Diceva spesso: “Non puoi suonare bene se non ti senti bene”. Per lui, sentirsi bene significava presentarsi sempre impeccabile.
Nel 1969, per il suo 70° compleanno, il presidente Richard Nixon invitò Duke Ellington alla Casa Bianca e gli conferì la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza civile negli Stati Uniti. Durante la serata, Ellington improvvisò un concerto che fece la storia.
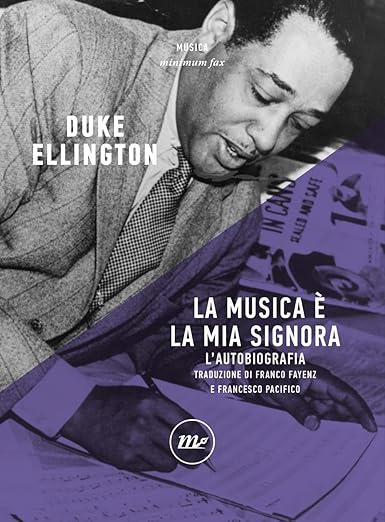
Una rievocazione affascinante della vita di Duke Ellington, dal Cotton Club alle grandi suite, raccontata con aneddoti, viaggi, collaborazioni e riflessioni, sempre sotto il segno dell’amore eterno per la musica.
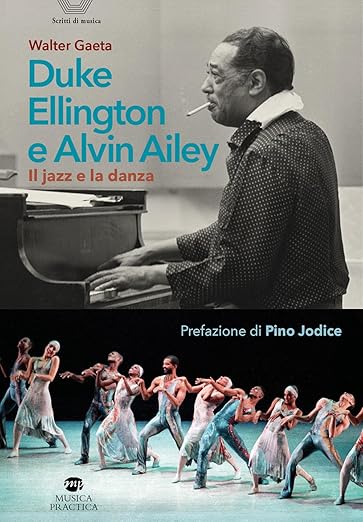
Un viaggio tra jazz e danza moderna attraverso Duke Ellington e Alvin Ailey, con analisi storiche, opere iconiche, immagini, partiture ed esempi audio che raccontano l’incontro di due linguaggi artistici universali.
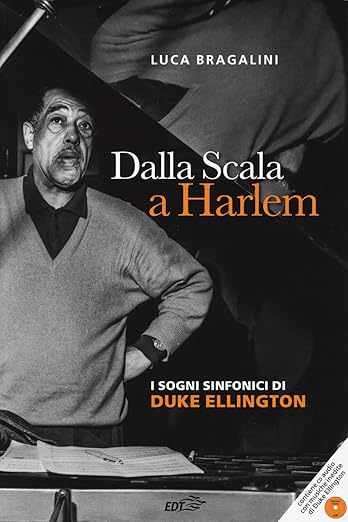
Un’indagine appassionante sul lato sinfonico di Duke Ellington, dalla misteriosa registrazione milanese alle connessioni con arte, politica e Harlem, rivelando un compositore innovativo e impegnato oltre i confini del jazz tradizionale.